L’uso sconsiderato e retorico della parola amore inclina al sospetto verso i numeri: chi fa i conti non ama. Al povero Pietro disposto a perdonare sette volte, Cristo ribatte con una cifra che, per il suo valore simbolico, evoca l’infinito: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette» (Mt 18,21-22). Tuttavia, Gesù risponde all’apostolo calcolatore con un altro numero. Meglio: con il prodotto ottenuto dalla moltiplicazione di due fattori. Insomma, il Salvatore replica a colpi di aritmetica. Un tocco di ironia. Prima di descrivere l’amore smisurato del pastore che cerca la pecora perduta (comunque, ha contato i suoi animali, accorgendosi che ne mancava uno…) e prima di rivelare la misericordia immensa del papà del figliol prodigo (Lc 15), il Signore, per ben due volte, esige dai discepoli capacità di «calcolo». Chi lo segue deve saper computare, come chi conta i soldi prima di iniziare un cantiere, o enumera i soldati in vista della guerra (Lc 14,28-33). Altro che nell’amore i conti non tornano: il numero preciso dei talenti affidati deve essere restituito moltiplicato, almeno per due (Mt 25,14-30).
Non esiste un’allergia evangelica ai numeri. Pure in questo il Nuovo Testamento è nel solco dell’Antico. Infatti, nel Salterio leggiamo che un «cuore saggio» è anche frutto di matematica, attraverso il calcolo dei propri giorni. Sapendoli contati, il saggio non rimanda all’infinito le decisioni da prendere; non impone, non si impone, non si lascia imporre pesi che solo la smisurata superbia riesce a immaginare. Per questo prega dicendo: «Gli anni della nostra vita sono settanta, ottanta», «insegnaci a contare i nostri giorni» (Sal 89,10.12). La retorica antinumerica sottenderebbe una rimozione della morte? Scrivendo della moderazione di Dio verso i nemici di Israele, il libro della Sapienza argomenta che essa è perfettamente coerente al suo stile di Creatore. Infatti, «egli ha disposto ogni cosa con misura, calcolo e peso» (Sap 11,20). Al Creatore è piaciuto fare ogni cosa misurabile, calcolabile, enumerabile. Stando a Sapienza, la misurabilità delle cose non indica innanzitutto il limite, ma rivela nel Creato la moderazione di Dio, misurato perfino quando castiga. Inoltre, le cose risultano misurabili e calcolabili poiché non sono mescolate in un continuum confuso e caotico, ma distinte, dotate di contorni e profili unici. Perciò emergono dal nulla e ciascuna ha consistenza e dignità. La fisica contemporanea rafforza l’idea, dimostrando che niente – né forme né forze, né macro né micro – è “continuo”, ma tutto esiste nella distinzione. In termini fisici e matematici: tutto è “discreto”, cioè misurabile. La discrezione avvolge ogni cosa. Anche nella misurabilità delle cose vibra la gloria del Santo dei Santi. Lo si nota fin dalla prima pagina della Bibbia. Dio crea interrompendo un continuum informe e tenebroso. Separando, realizza qualcosa di nominabile – “giorno” e “notte”, “cielo” e “terra” – e numerabile: «primo… secondo… terzo giorno», un cielo e una terra. Le cose vengono alla luce non solo grazie ai nomi e le parole, ma anche per mezzo dei numeri. Come i nomi, anche i numeri distinguono, indicano e mettono in relazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Abbonati a Luoghi dell’Infinito per continuare a leggere
La rivista è disponibile in formato cartaceo e digitale
Abbonati alla rivistaSei già registrato? Accedi
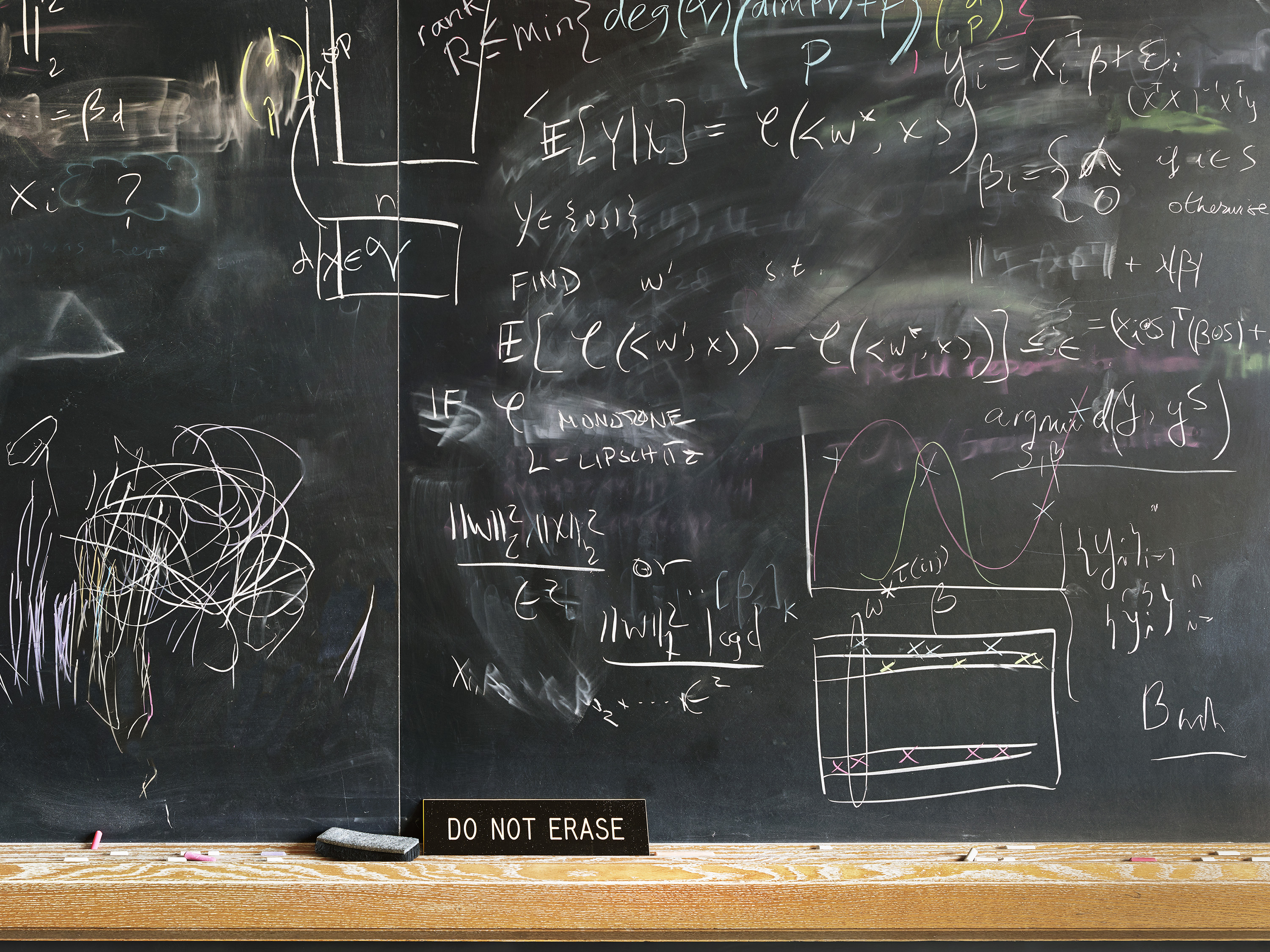

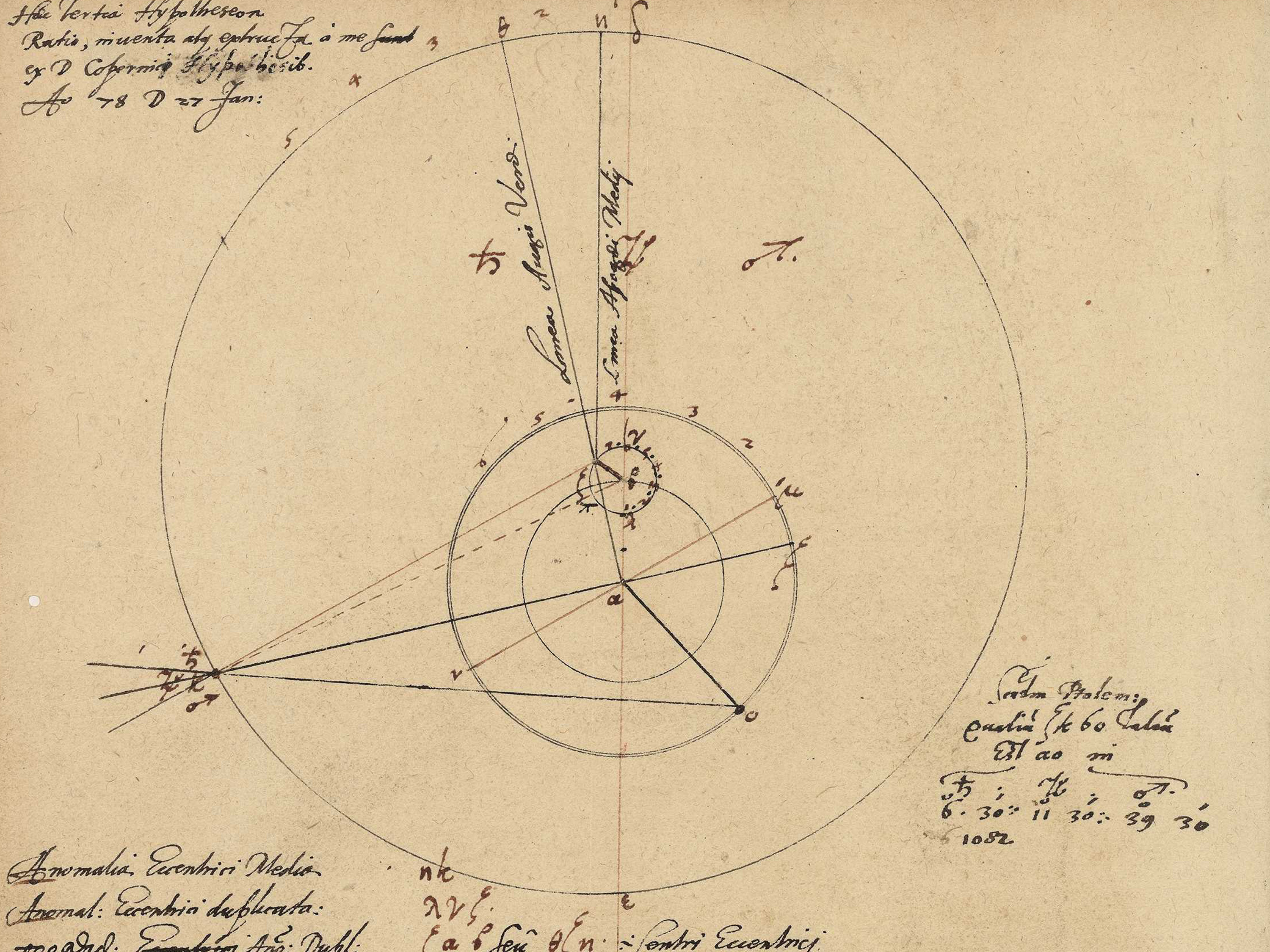



 Home
Home
 Avvenire
Avvenire

 Mondo CEI
Mondo CEI



